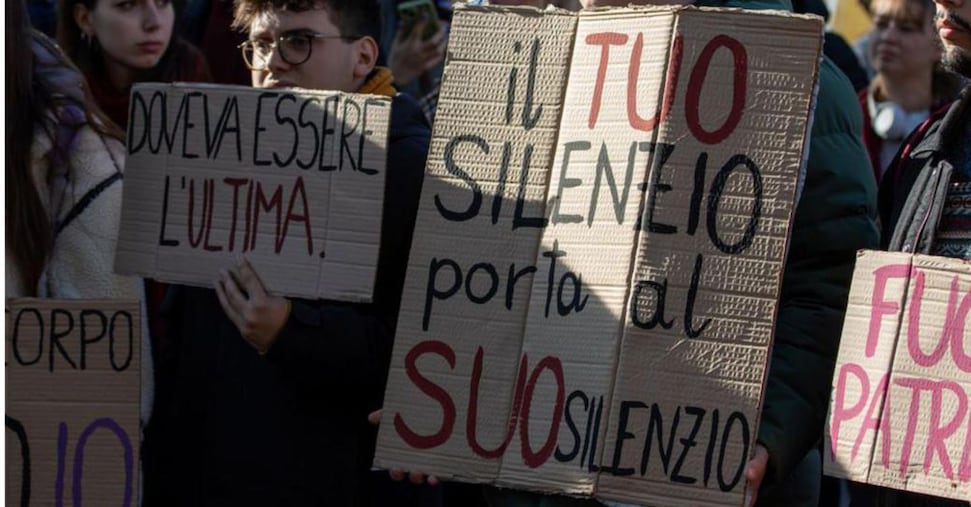Segreti indicibili tra i mormoni
C’è sempre qualcosa di morbosamente magnetico nella storia di un delitto efferato in una piccola comunità esotica, come ben dimostra In nome del cielo (su Disney+ dal 31 agosto), true crime ambientato nei sobborghi di Salt Lake City, una città in cui i mormoni costituiscono il 50% della popolazione. Basata sull’omonimo libro di Jon Krakauer (uscito in Italia per Corbaccio nel 2003), la serie drammatizza fatti reali: la devota mormona Brenda Lafferty e la sua bambina di 15 mesi furono brutalmente uccise nel luglio del 1984 da persone interne alla comunità.
In nome del cielo procede con la solenne lentezza dei crime di prestigio, senza correre verso la soluzione, più attenta all’atmosfera e all’analisi psicologica che ai colpi di scena. Con innegabile rispetto per le vittime e per la complessità degli eventi, la serie si muove su tre linee temporali: nel presente, le indagini portate avanti da una strana coppia di detective, il mormone Jeb Pyre (Andrew Garfield) e l’ateo Bill Taba (Gil Birmingham), di discendenza nativo-americana; nel passato recente, l’ingresso di Brenda nella famiglia Lafferty, come moglie dell’ultimogenito, fino al suo omicidio; nel passato remoto, gli anni fondativi del mormonismo e i peccati originali della sua Chiesa.
L’accurata e realistica ricostruzione degli anni ’80 ci ricorda l’ormai quasi dimenticata differenza tra una storia ambientata in quegli anni e l’estetica della nostalgia; meno riuscite le sequenze ottocentesche sulla storia mormona, che a volte sembrano un corpo estraneo come gli inserti drammatici di una puntata di Superquark. La loro necessità, però, diventa chiara quando si inizia a capire la connessione tra il delitto, il fondamentalismo mormone e le contraddizioni profondamente radicate nel credo stesso del mormonismo mainstream.
Tra i molti aspetti positivi, ci sono però almeno due problemi che affliggono In nome del cielo: innanzitutto una prolissità seriosità, che allunga inutilmente tutti gli episodi a oltre un’ora di durata; poi la tendenza a mettere costantemente in primo piano Andrew Garfield e il conflitto interno al suo personaggio, che non sempre l’attore sa rendere adeguatamente. Espandere il ruolo del bravissimo Gil Birmingham, forse, avrebbe reso più coinvolgente la visione.
In nome del cielo
Fonte: Il Sole 24 Ore